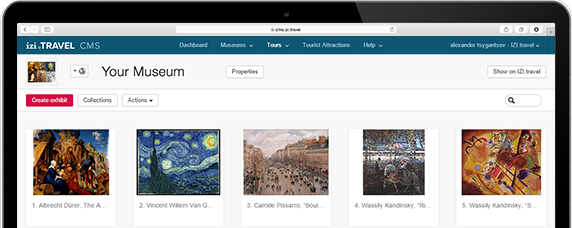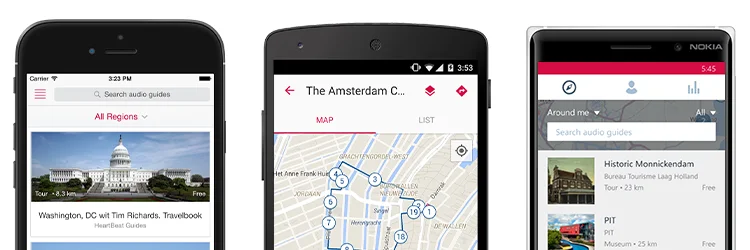Audioguía 4_IL TEATRO ROMANO DI AREZZO_it
2 sights
- Resumen de audiotour
-
Resumen de audiotour
Un monumentale edificio per spettacoli sorgeva in età romana sul versante del Colle di San Donato che scende verso l’area di Colcitrone, nota anche come di Porta Crucifera. A questo era collegato, più a valle, un grande complesso termale. Si tratta di un imponente teatro in muratura con una cavea semicircolare di almeno 90 metri di diametro, visibile dalla città e dal territorio circostante. Oggi ne rimane visibile una minima porzione: è infatti conservata solo la base della struttura che sosteneva le gradonate per gli spettatori, riconoscibile per il suo andamento curvilineo nei terreni posti tra i bastioni del Belvedere e della Chiesa e viale Buozzi; è costruita con una sorta di calcestruzzo (opus caementicium) composto da pietre mescolate a malta e in origine doveva avere un rivestimento esterno in blocchetti di pietra (opus reticulatum o incertum), oggi non più conservato. L’edificio teatrale, in epoca medievale probabilmente in parte conservato e in parte inglobato nelle strutture di difesa che caratterizzavano questa parte alta della città, fu ulteriormente distrutto nel corso del Cinquecento a seguito della realizzazione della Fortezza. Porzioni della struttura in opera cementizia rimasero comunque visibili nel corso dei secoli nei campi sottostanti alla Fortezza. Le sostruzioni con andamento curvilineo risultano disegnate e ben riconoscibili nella pianta della Fortezza realizzata nel 1749 dal Colonnello Odoardo Warren su commissione dei Granduchi di Lorena. Altre parti dell’edificio teatrale finirono invece interrate dai consistenti riporti di terra conseguenti alla costruzione della Fortezza. Furono viste e indagate nel corso di alcuni scavi condotti agli inizi dell’Ottocento dell’aretino Giovanni Guillichini nei terreni a valle dell’attuale viale Buozzi (all’epoca non ancora realizzato). Di queste indagini, condotte nel 1833, rimangono preziose relazioni oggetto di alcune comunicazioni all’Accademia Petrarca di Arezzo da parte dello stesso Guillichini: vennero portati alla luce il piano di preparazione in cocciopesto dell’orchestra o platea (lo spazio più prossimo al palcoscenico, in epoca romana occupato dai posti dei cittadini più illustri), in origine pavimentata con materiali pregiati, e il muro di fondazione in laterizio della frons scenae (struttura che si elevava al di là del palcoscenico costituendo una sorta di fondale); anch’essa era in origine rivestita di marmi colorati e decorata da elementi architettonici in terracotta, materiali rinvenuti in grande quantità nel corso degli scavi anche se in stato frammentario. Fu realizzato un rilievo delle strutture emerse e parte dei reperti rinvenuti furono acquisiti dal Museo cittadino della Fraternita dei Laici. Alcuni elementi in pietra, tra cui una colonna in rocchi di arenaria, recuperati sempre nell’Ottocento ma appartenenti a epoche diverse, sono invece visibili lungo la strada denominata vicolo delle Terme. Negli scavi di Guillichini furono infatti individuati a ridosso del muro di fondo del teatro una cisterna ed alcuni vani che presentavano alle pareti tubuli fittili e che sono interpretabili come ambienti “caldi”, cioè riscaldati, di un complesso termale prossimo e connesso all’edificio teatrale stesso, secondo un’associazione “teatro-terme” molto frequente in epoca romana. A questo edificio termale doveva appartenere anche il grande ambiente scoperto nel 1933 presso Porta Crucifera decorato con un mosaico a tessere bianche e nere raffigurante Nettuno con un carro tirato da cavalli marini, oggi conservato al Museo Archeologico “C. Cilnio Mecenate” di Arezzo. In questa grande aula con pavimento a mosaico fu recuperata anche la nota ara marmorea cosiddetta del “Lupercale”, anch’essa esposta nel Museo di Arezzo, che mostra l’allattamento di Romolo e Remo da parte della Lupa capitolina alla presenza del pastore Faustolo e del dio Marte, protettore dei due gemelli. La realizzazione negli anni Trenta del Novecento del viale del Re (attuale viale Bruno Buozzi) comportò ulteriori trasformazioni: a valle, le strutture viste e indagate nell’Ottocento finirono nuovamente interrate a seguito dei lavori di livellamento del versante del colle di San Donato; a monte inoltre, una ulteriore porzione della sostruzione curvilinea della cavea fu distrutta per far posto al nuovo tracciato stradale, come risulta evidente dal troncone di muratura ben visibile ancora oggi sul margine del viale all’incirca all’altezza del Bastione del Belvedere. La tecnica di costruzione e i rivestimenti pavimentali e decorativi descritti nell’Ottocento hanno indotto gli studiosi a collocare l’edificazione del teatro tra l’età augustea/giulio-claudia e quella flavia, nel corso quindi del I sec. d.C.
- 1 il teatro romano di Arezzo
-
Resumen de audiotour
Un monumentale edificio per spettacoli sorgeva in età romana sul versante del Colle di San Donato che scende verso l’area di Colcitrone, nota anche come di Porta Crucifera. A questo era collegato, più a valle, un grande complesso termale. Si tratta di un imponente teatro in muratura con una cavea semicircolare di almeno 90 metri di diametro, visibile dalla città e dal territorio circostante. Oggi ne rimane visibile una minima porzione: è infatti conservata solo la base della struttura che sosteneva le gradonate per gli spettatori, riconoscibile per il suo andamento curvilineo nei terreni posti tra i bastioni del Belvedere e della Chiesa e viale Buozzi; è costruita con una sorta di calcestruzzo (opus caementicium) composto da pietre mescolate a malta e in origine doveva avere un rivestimento esterno in blocchetti di pietra (opus reticulatum o incertum), oggi non più conservato. L’edificio teatrale, in epoca medievale probabilmente in parte conservato e in parte inglobato nelle strutture di difesa che caratterizzavano questa parte alta della città, fu ulteriormente distrutto nel corso del Cinquecento a seguito della realizzazione della Fortezza. Porzioni della struttura in opera cementizia rimasero comunque visibili nel corso dei secoli nei campi sottostanti alla Fortezza. Le sostruzioni con andamento curvilineo risultano disegnate e ben riconoscibili nella pianta della Fortezza realizzata nel 1749 dal Colonnello Odoardo Warren su commissione dei Granduchi di Lorena. Altre parti dell’edificio teatrale finirono invece interrate dai consistenti riporti di terra conseguenti alla costruzione della Fortezza. Furono viste e indagate nel corso di alcuni scavi condotti agli inizi dell’Ottocento dell’aretino Giovanni Guillichini nei terreni a valle dell’attuale viale Buozzi (all’epoca non ancora realizzato). Di queste indagini, condotte nel 1833, rimangono preziose relazioni oggetto di alcune comunicazioni all’Accademia Petrarca di Arezzo da parte dello stesso Guillichini: vennero portati alla luce il piano di preparazione in cocciopesto dell’orchestra o platea (lo spazio più prossimo al palcoscenico, in epoca romana occupato dai posti dei cittadini più illustri), in origine pavimentata con materiali pregiati, e il muro di fondazione in laterizio della frons scenae (struttura che si elevava al di là del palcoscenico costituendo una sorta di fondale); anch’essa era in origine rivestita di marmi colorati e decorata da elementi architettonici in terracotta, materiali rinvenuti in grande quantità nel corso degli scavi anche se in stato frammentario. Fu realizzato un rilievo delle strutture emerse e parte dei reperti rinvenuti furono acquisiti dal Museo cittadino della Fraternita dei Laici. Alcuni elementi in pietra, tra cui una colonna in rocchi di arenaria, recuperati sempre nell’Ottocento ma appartenenti a epoche diverse, sono invece visibili lungo la strada denominata vicolo delle Terme. Negli scavi di Guillichini furono infatti individuati a ridosso del muro di fondo del teatro una cisterna ed alcuni vani che presentavano alle pareti tubuli fittili e che sono interpretabili come ambienti “caldi”, cioè riscaldati, di un complesso termale prossimo e connesso all’edificio teatrale stesso, secondo un’associazione “teatro-terme” molto frequente in epoca romana. A questo edificio termale doveva appartenere anche il grande ambiente scoperto nel 1933 presso Porta Crucifera decorato con un mosaico a tessere bianche e nere raffigurante Nettuno con un carro tirato da cavalli marini, oggi conservato al Museo Archeologico “C. Cilnio Mecenate” di Arezzo. In questa grande aula con pavimento a mosaico fu recuperata anche la nota ara marmorea cosiddetta del “Lupercale”, anch’essa esposta nel Museo di Arezzo, che mostra l’allattamento di Romolo e Remo da parte della Lupa capitolina alla presenza del pastore Faustolo e del dio Marte, protettore dei due gemelli. La realizzazione negli anni Trenta del Novecento del viale del Re (attuale viale Bruno Buozzi) comportò ulteriori trasformazioni: a valle, le strutture viste e indagate nell’Ottocento finirono nuovamente interrate a seguito dei lavori di livellamento del versante del colle di San Donato; a monte inoltre, una ulteriore porzione della sostruzione curvilinea della cavea fu distrutta per far posto al nuovo tracciato stradale, come risulta evidente dal troncone di muratura ben visibile ancora oggi sul margine del viale all’incirca all’altezza del Bastione del Belvedere. La tecnica di costruzione e i rivestimenti pavimentali e decorativi descritti nell’Ottocento hanno indotto gli studiosi a collocare l’edificazione del teatro tra l’età augustea/giulio-claudia e quella flavia, nel corso quindi del I sec. d.C.
Reseñas
Descargue la app gratuita de izi.TRAVEL
¡Cree sus propias audioguías!
La utilización del sistema y la app de guía para móvil es gratuita